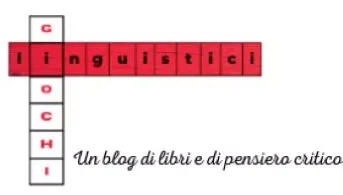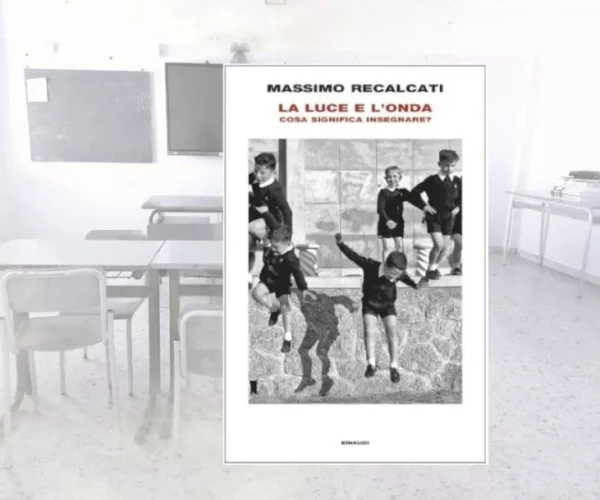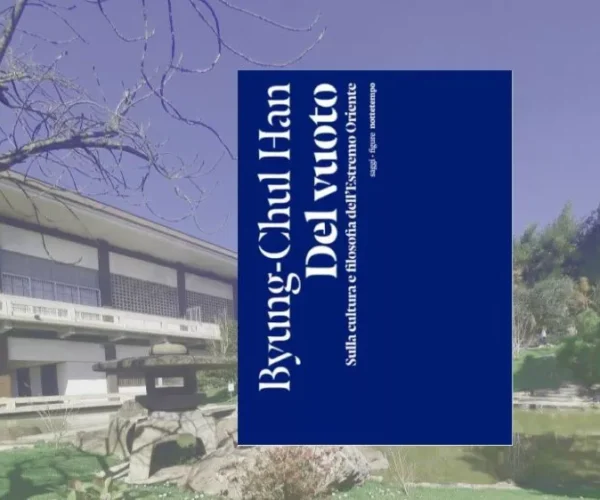La definisce un’indagine della ragione – prettamente – umana, quella che la porta a interrogarsi sul nesso tra natura e morale. Sì, perché ogni tentativo di dare delle risposte al modo di agire degli uomini, sembra scontrarsi con quel “siamo fatti così” del funzionamento della nostra ragione.
Ma prima della risposta viene la domanda e Lorraine Daston – filosofa americana e direttrice dal 1990 dell’Istituto Max Planck di Berlino – si chiede “perché gli esseri umani guardano alla natura come una fonte di norme per la condotta umana?”
Contro natura – pubblicato per la prima volta nel 2019 e tradotto in italiano da Assunta Martinese per Timeo edizioni – cerca di dare una risposta a questo quesito.
L’assunto da cui parte Lorraine Daston è quello presupposto dalla domanda e cioè: l’uomo nel corso dei tempi ha sempre preso ad esempio la natura per ricavarne un giudizio di tipo morale intorno a ciò che è giusto o sbagliato. Sarebbe la natura a fornire un modello di condotta normativo. Ma la natura, essendo una parola/contenitore piuttosto complessa e multiforme, si presta a sostegno ora dell’una ora dell’altra argomentazione, tra loro anche conflittuali. Un problema che sembra avvalorare quello che da Moore in poi è noto nell’ambito della filosofia della scienza come fallacia naturalistica.
Tuttavia la tendenza a derivare norme dalla natura persiste. Perché? La risposta di Daston, in Contro natura, è, come si era anticipato, a causa della ragione umana, di quel “siamo fatti così”. Sì, ma in che modo? La razionalità umana è fatta in modo tale da tendere a rintracciare ed estrapolare l’ordine e la normatività. E queste chiaramente abbondano nella natura. Daston divide la marea di ordini da estrapolare dalla natura in tre categorie: le nature specifiche, le nature locali e le leggi universali. Per ognuna di esse indica l’eccezione che può scaturire da quest’ordine e l’emozione che il presentarsi dell’eccezione genera negli uomini.
- Un esempio sono le specie naturali, siano esse vegetali o animali, – problematica è in questo contesto l’inclusione degli uomini in categorie definibili come razze, considerati i terribili esiti – e un’eccezione a questo modello d’ordine sono le specie ibride come il mulo, per esempio, che nasce dall’unione di due specie animali diverse, cavallo e asino. Sono considerati mostri e generano orrore.
- Le nature locali fanno riferimento all’ordine che si trova nella flora, fauna, clima e geologia, cioè negli ambienti. L’armonia e l’equilibro dei luoghi può essere sovvertito dalle eccezioni note come catastrofi naturali, generano timore.
- Le leggi naturali sono gli ordini propri dei fenomeni naturali, esempio ne è la legge della gravitazione, le eccezioni sono i miracoli e il libero arbitrio. Generano stupore.
Il fatto che le eccezioni alle regole naturali provochino queste emozioni, ha per presupposto che gli uomini conoscano la regolarità e che abbiano delle aspettative al riguardo. L’aspettativa non raggiunta, la non coincidenza tra com’è e come dovrebbe essere fa scaturire queste emozioni negli uomini.
L’eccezione, come sempre in scienza e non solo – a questo proposito Paolo Pecere cita nella sua prefazione a Contro natura l’esempio di Popper: «già Karl Popper riconosceva che un caso che falsifica una legge produce una conoscenza più ricca di uno che sembra confermarla» – si rivela il potente mezzo attraverso il quale il meccanismo viene alla luce: il come dovrebbe essere viene prepotentemente alla ribalta.
Questo come dovrebbe essere ci mostra il rimando alla generica regolarità della natura, la normatività “il principio che conferisce a tutte le norme la loro forza”. Questa generica normatività, al di sopra delle categorie degli ordini, può essere vista come la facoltà di normalizzare. Arrivati alla generica facoltà il discorso della Daston prende una direzione che non si può non accostare a quella della facoltà del linguaggio, tanto più quanto nel mio caso, gli studi di filosofia del linguaggio hanno i loro effetti.
Tanto nel caso della facoltà della normatività, quanto quella del linguaggio si arriva ai limiti della conoscenza umana, visto che non si può guardarla dal di fuori, ogni ulteriore tentativo di spiegazione porterebbe ad un regresso all’infinito. Il paragone con il linguaggio non si ferma qua, quando parla di normalità, l’ordine ricorrente nella natura, non parliamo forse anche della ricorsività linguistica?
Spiegando poi il funzionamento delle norme, del loro ripetersi e del bisogno di una comunità come presupposto alla loro esistenza, Daston si muove nel campo del secondo Wittgenstein. L’argomentazione di Daston corre in parallelo alle critiche di Wittgenstein all’idea di una lingua privata quando scrive “non possono esistere norme esclusivamente private” ed ancora quando si chiede come la comunità applichi una norma. Il parallelo con il “seguire una regola” delle Ricerche filosofiche, mi sembra più che calzante.
Lorraine Daston sostiene che la normatività presuppone l’ordine, l’uscita dal caos dove tutto è incerto, ma tutto questo non lo richiede forse anche la lingua? La lingua per poter passare all’atto non ha forse bisogno di rompere con l’indeterminatezza, dove tutto il generico dire è possibile?
Daston, che è una filosofa della scienza e non del linguaggio, non trasla le sue conclusioni direttamente sul piano linguistico. Parla della ragione umana e quindi degli uomini definendoli, con una citazione presa in prestito dal filosofo Ian Hacking, come “rappresentatori”, tanto più che, “ Le persone creano rappresentazioni”. Sarebbe questa caratteristica umana, forse la più umana di tutte stando a Hacking, a motivare il nesso tra norme, ordine e natura. Ma la capacità di rappresentare non rientra forse nel mondo dell’animale linguistico? La risposta potrebbe facilmente slittare al perché il nostro logos, alla maniera greca di ragione e linguaggio, funzioni così.
Magari per i marziani e per gli angeli l’ordine è e basta, e non ha bisogno di rappresentazione. Ma per la nostra specie, con il nostro apparato sensoriale, gli ordini devono essere compresi e immaginati, sia in senso letterale sia in senso figurato.
– Contro natura di Lorraine Daston
Per Lorraine Daston, in conclusione, il problema non risiede nel fatto che l’uomo trae le sue norme dalla natura. L’uomo lo fa in maniera empirica e lo fa perché la natura è onnipresente e provvista di ordini che eccedono la ragione umana. Il problema sorge, piuttosto, quando l’uomo vuole imporre alcuni ordini come gli unici possibili, sopprimendo così la pluralità, la polifonia di questa caotica Wunderkammer che è la natura.
Scheda del libro Contro natura

Titolo: Contro natura
Autore: Lorraine Daston
Casa editrice: Timeo edizioni
Anno di pubblicazione: 2024 (in Italia)
Numero di pagine: 100
Traduzione di Assunta Martinese