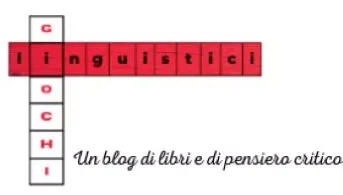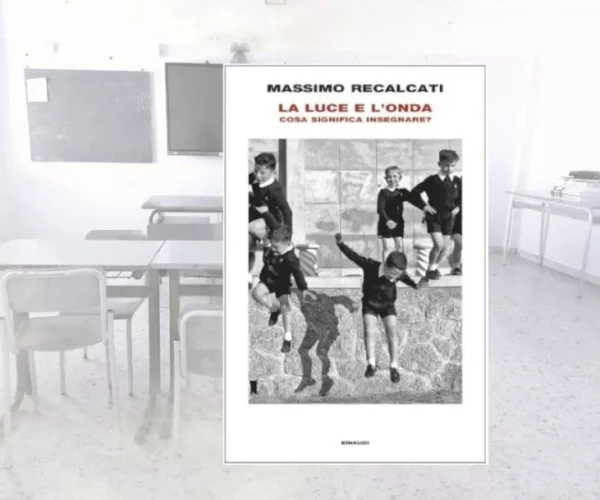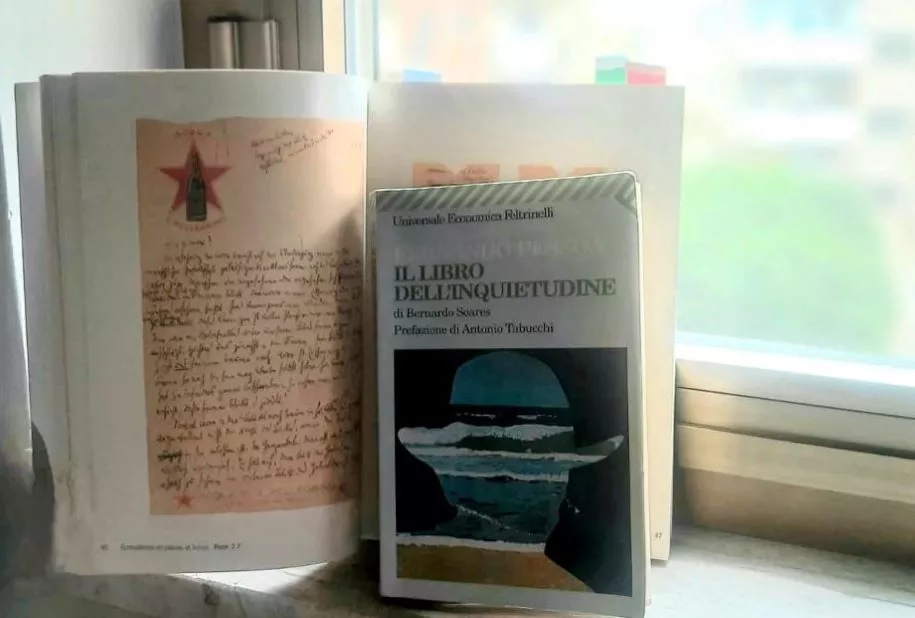
Un parallelo tra Walter Benjamin e Fernando Pessoa (e uno dei suoi eteronimi: Bernando Soares)
Mentre, nell’Europa centrale, il tedesco Walter Benjamin individuava nel flâneur, e rispettivamente nello spazio dei passages di Parigi, la figura emblematica della città moderna del XX secolo – così come nel fruitore distratto la nuova figura dell’inizio del XXI secolo – dall’altra parte dell’Europa, nel profondo sud-ovest, un altro pensatore, un’anima sensibile e malinconica – almeno quanto quella di Benjamin – coglieva il sentire di un’epoca, di un luogo, Lisbona, fino a diventarne lui stesso l’emblema. Sì, perché Pessoa è Lisbona e Lisbona è Pessoa.
Si potrebbe dire anche di Benjamin che incarni lui stesso l’anima del flâneur, ma in un certo senso lo fa solo a metà, a causa di quel suo errare di luogo in luogo alla ricerca di un posto in cui sentirsi al riparo; per Fernando Pessoa, dopo il rientro dal Sudafrica, non ci sarà altro riparo che Lisbona. I viaggi, tutti mentali, li compirà nella sua tormentata interiorità. Ma se Benjamin fugge da un male concreto, il nazismo del secolo scorso, Pessoa è braccato dalla sua stessa anima. Per entrambi la loro malinconia sottende eine Unruhe, Desassossego, Inquietudine, o, come meglio rappresentano i prefissi privativi Un- e Des-, una mancanza di tranquillità.
Walter Benjamin e Fernando Pessoa sono due introversi, nati entrambi alla fine dell’Ottocento e vissuti nella prima metà del Novecento, che osservano il loro mondo, la loro epoca. Ma se lo sguardo di Benjamin ha una lunghezza d’ampio raggio, estesa sia in sincronia che in diacronia, quello di Pessoa è circoscritto ai confini spaziali che riesce ad abbracciare dalla sua finestra, quella su Rua dos Douradores . Antonio Tabucchi ha definito Bernando Soares (il semieteronimo di Pessoa ne Il libro dell’inquietudine) come “un uomo che sta a una finestra”, e, allo stesso tempo, mai descrizione migliore si potrà dare di Fernando Pessoa. Dell’uomo alla finestra, Pessoa, come Soares, ha la capacità di osservare il mondo che si svolge, direttamente, al di fuori di essa. Lo sguardo di Pessoa non è quello del sociologo che osserva i cambiamenti della sua società, nel suo caso il Portogallo che si avvia alla deriva della dittatura salazariana. L’osservare di Pessoa si limita a ciò che i suoi occhi vedono, all’interno del loro perimetro. Un perimetro per lo più urbano, dove l’uomo comune, il co-umano inconsapevole, è preso sotto la lente di ingrandimento delle riflessioni del poeta. È singolare che il suo cognome, Pessoa, significhi in portoghese proprio persona, se si pensa che è proprio “la persona”, con il suo sentire, il centro della sua poetica. Osserva il cuoco, il cameriere, il postino nella routinaria fatica del vivere. L’osserva e vi riconosce il proprio mal di vivere.
“In certi giorni, in certe ore che mi reca chissà quale brezza, che mi apre chissà quale porta che si apre, sento all’improvviso che il droghiere dell’angolo è un ente spirituale, che il commesso che in questo momento si affaccia sulla porta sopra il sacco di patate è un’anima capace di soffrire. “
Fernando Pessoa – Il libro dell’inquietudine
Per questo il suo guardare alla finestra deve necessariamente essere anche, e soprattutto, un guardare dentro se stesso. Il suo sguardo introspettivo è quello di un poeta in conflitto con il suo IO, o meglio i suoi molti Io interiori: gli eteronimi per l’appunto.
E non è un caso che Walter Benjamin e Fernando Pessoa, entrambi lacerati nel loro bilinguismo – una lingua madre, il tedesco, per Benjamin, che si rivolta contro se stessa perché diventa la patria dell’oppressore, e un francese amato, ma lingua d’esilio. Una lingua madre, il portoghese, per Pessoa, perduta e poi ritrovata, e un inglese che rimarrà un secondo porto per il suo io, tanto che le sue due uniche opere poetiche pubblicate in vita sono appunto in inglese. –, hanno preferito la forma frammentaria, a mo’ di aforismi, nei loro scritti. Scritti che appuntano su pezzi di carta rimediati alla bella e buona, per non lasciar sfuggire il Blitz, per fissare con la parola scritta il lampo di un’idea. Il frammento, molto più che l’opera sistematica, esprime il carattere di lacerazione della loro epoca e del lor mondo interiore. Un frammento che è il tutto.
La loro scrittura, molto volte oscura e enigmatica, è innanzitutto un lavoro su loro stessi. È nella scrittura che Fernando Pessoa ricerca il balsamo per la sua anima, il tanto agognato sossego. Ed è sempre in essa che dà sfogo alla sua “isteria” – e forse ne cerca una cura – creando personaggi con un’identità fittizia, ma dotati di una biografia completa, che sembrano “agire” nella scrittura con una loro peculiare e autonoma personalità. Gli eteronimi – se ne possono contare più di 100 disseminati nelle sue opere, i più conosciuti restano: Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Ricardo Reis e il semi-eteronimo Bernando Soares – sono qualcosa di diverso rispetto allo pseudonimo – come Agesilaus Santander, quello usato da Benjamin, ad esempio – questi esprimono, nel loro cosmo letterario, il loro personale punto di vista come se fosse davvero indipendente da quello dell’autore.
“vivere è essere un altro”
Ho creato in me varie personalità. Creo costantemente personalità. Ogni mio sogno, appena lo comincio a sognare è incarnato da un’altra persona che inizia a sognarlo, e non sono io.
Fernando Pessoa
Non è solo con gli eteronimi che Fernando Pessoa porta la psicoanalisi nella letteratura, anche con la dimensione del sogno indaga nella scrittura, uno degli oggetti principali delle teorie psicoanalitiche.
Ponendosi nel tra dei suoi molteplici eteronomi, così come nel tra del sogno e della realtà – in quel suo neologismo sdormo –, Pessoa indaga le forme liminari dell’esperire umano.
Benjamin e Pessoa non si conobbero, la fama dell’uno, così come dell’altro, non fu in vita tale da permetterlo. Eppure i loro percorsi, che corrono paralleli sui binari della storia dello scorso secolo, hanno un altro punto di giuntura nella loro fine precoce, drammatica ma leggendaria. I due pensatori, chiamati alla morte per diverse circostanze, rispettivamente all’età di 48 anni Benjamin e 47 Pessoa, lasciarono ai posteri degli scritti incompiuti – la pesante valigia che Benjamin trasportò fino in Spagna, dove si tolse la vita per sfuggire al nazismo, e il baule pieno di scritti sparsi lasciato da Pessoa – , che daranno non poco lavoro ai curatori e su cui si costruisce, in parte, la loro leggenda.