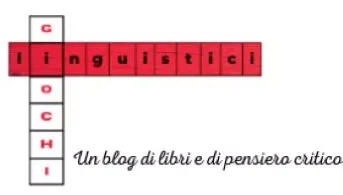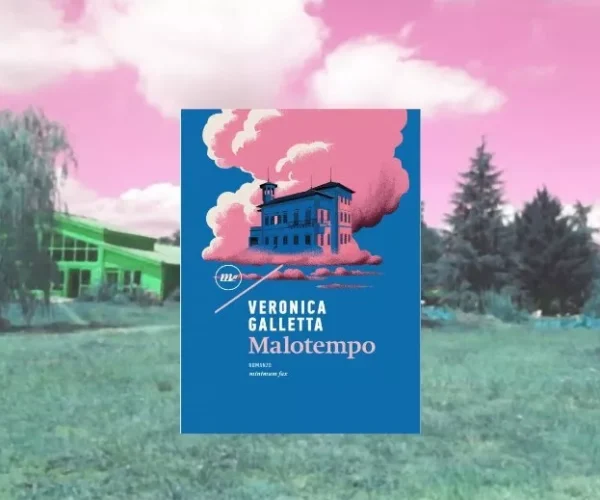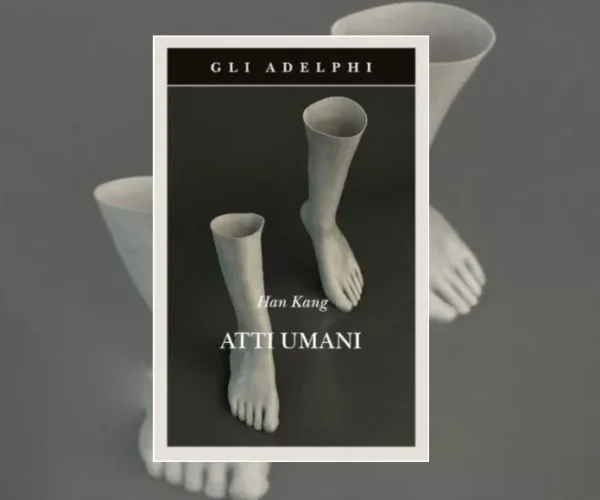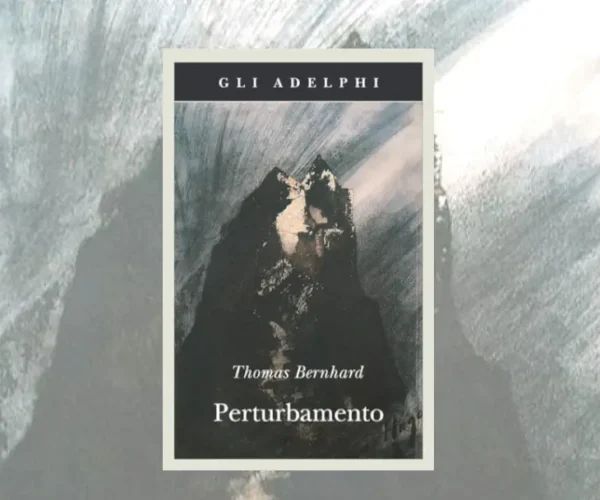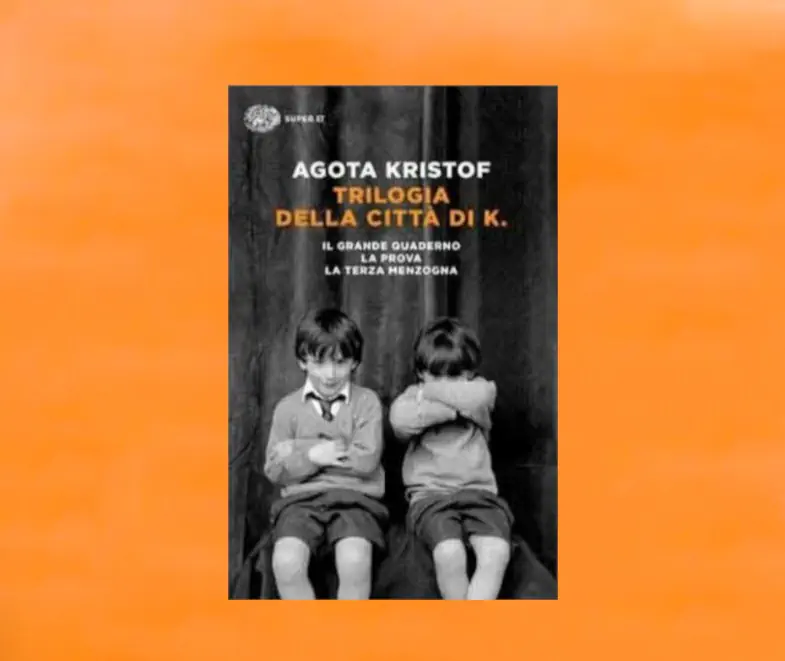
Se dovessi indicare la lettura che più ha lasciato il segno tra i libri letti negli ultimi tempi, indicherei, senza troppe esitazioni e senza grandi sorprese, La trilogia della città di K. di Ágota Kristóf.
La scelta non desterà tanto stupore, perché già molti altri prima di me, sui social e nel mondo intellettuale con un autore del calibro di Slavoj Žižek, hanno espresso lo stesso parere. Se è vero che nella vita di un lettore avviene costantemente di incappare in letture stimolanti, è anche vero che molte lasciano indifferenti; è soprattutto l’elemento sorpresa che svanisce facendo ricadere le storie nell’ambito del prevedibile e del già visto.
De La trilogia della città di K. non si può certo negare che sia un’esperienza letteraria sconvolgente. Turbante e ammiccante, disturbante e nostalgico allo stesso tempo non si può nemmeno passar oltre al fatto che non sia una lettura bella in un senso canonico, né per tutti i gusti, o per meglio dire per tutti gli stomaci. Ma c’è qualcosa oltre la disperazione, oltra la solitudine e la crudeltà. Ágota Kristóf lo nasconde, lo aggroviglia, per mostrarlo poi come protagonista della storia questo qualcosa, che altro non è se non il potere della finzione narrativa stessa.
I tre libri
Più che iniziare raccontando l’aggrovigliatissima trama de La trilogia della città di K., è necessario spiegarne la struttura. Il volume, che viene visto come un tutt’uno, è in realtà composto da tre libri, apparsi in edizioni separate a distanza di pochi anni tra loro.
- Il grande quaderno (Le Grand Cahier; 1986)
- La prova (La Preuve; 1988)
- La terza menzogna (Le Troisième Mensonge; 1991)
I libri, seppur costituiscano delle unità complete in sé, sono davvero comprensibili solo in una prospettiva d’insieme. Ricalcano, infatti, una struttura di tipo dialettica con Il grande quaderno e La prova corrispondenti ai termini di tesi e antitesi e La terza menzogna fungente da sintesi tra i due. I tre libri constano di continui rimandi, stessi episodi narrati e rinarrati in maniera diversa, da un’altra prospettiva, incroci di vite che si assumono e si negano in una continua sequenza di verità e finzioni di cui è difficili discernere delle certezze, almeno fino al finale rivelatore.
E poi c’è la piccola cittadina di frontiera, nominata solo con la lettera iniziale K., di cui non conosciamo la localizzazione esatta, ma che non si fa fatica a collocare in una Nazione del blocco sovietico: potrebbe essere la Cecoslovacchia che confina con l’agognato ovest rappresentato dalla Germania, ma più verosimilmente l’autrice di origini ungheresi si sta riferendo alla sua terra, e con essa al suo travaglio.
Trama
Nel primo libro Il grande quaderno seguiamo le vicende di due gemelli di circa dieci anni che vengono affidati, dalla madre, alle cure della nonna con la speranza di assicurare loro la sopravvivenza duranti i difficili tempi della guerra. Siamo negli anni della Seconda guerra mondiale, anche se non viene mai specificato gli elementi per dedurlo non scarseggiano. La precarietà della loro situazione viene inasprita dal fatto che le “cure” della nonna non sono affatto amorevoli, l’anziana donna lavora da mattina a sera nelle sue terre, e lo stesso pretende dai nipoti a cui si rivolge per lo più con il termine “figli di cagna”.
Nonostante l’ambiente cupo e deprimente, gli inverni estremamente rigidi, l’ostilità degli altri ragazzini del paese, gli abusi degli adulti e la miseria, sorprendentemente, i due bambini riescono a cavarsela alla grande. Studiano da soli e riportano tutto su un quaderno – Il grande quaderno che dà il titolo, per l’appunto –, ed è proprio la loro grande intelligenza e forza di volontà a permettere loro non solo di mantenersi a galla, ma anche di aiutare chi si trova in difficoltà.
Che i due bambini siano dotati di un animo infinitamente buono? Non esattamente, a cattiveria reagiscono con cattiveria, si ergono a giudici per punire quelli che ritengono responsabili di cattive azioni e non esitano a ricorrere al ricatto per ottenere quello che vogliono. Ma no, sarebbe sbagliato definirlo così, non si tratta del volere, ma del bisogno. I due vivono in un mondo amorale, un mondo in cui la legge è sospesa dallo stato d’eccezione, le categorie del buono e del cattivo, del giusto e dello sbagliato diventano, perciò, troppo sfumate per poter essere usate come riferimenti. I due bambini usano la loro personale bussola interiore e sorprendentemente sembra funzionare.
Il secondo libro La prova riprende da dove il secondo si era interrotto, cioè con la separazione dei gemelli, uno è fuggito al di là della frontiera, l’altro è rimasto nella casa della nonna. Scopriamo che quello che è rimasto si chiama Lucas, il nome dell’altro è Claus. Seguiamo le vicende di Lucas dai suoi quindici anni in poi nella città di K. dove nulla è davvero cambiato, la Seconda guerra mondiale è terminata ma ora la popolazione è oppressa dalla dittatura (quella sovietica, supponiamo).
Lucas accoglie nella sua casa una ragazza madre con il suo bambino, fa compagnia al curato, avvia una relazione con una donna più grande, ma in ogni suo gesto si nasconde l’attesa del fratello. Salvo poi scoprire che, forse, questo suo fratello gemello non è mai esistito.
Il terzo libro e ultimo libro de La trilogia della città di K. è La terza menzogna. Esso svela la verità sul mistero dei gemelli. O, almeno, sembra volerla svelare, per quanto sia possibile parlare di “verità in universo, quello letterario, che fa della finzione la sua patria.
Una trilogia ungherese
La trilogia della città di K. è un libro visceralmente ungherese. Recentemente ho letto due dei più noti libri del Premio Nobel 2025, l’ungherese László Krasznahorkai, e approdare a Ágota Kristóf dopo queste letture, fa vedere tutto più chiaramente. Sarebbe già bastato Sándor Márai, con cui Ágota Kristóf condivide l’esperienza dell’esilio e del divenire apolide, a unire i puntini che restituiscono l’immagine di un paese senza requie, abitato da un popolo disperato, intrappolato in un’oppressione che arriva tanto da ovest, quanto da est. È in quei dettagli, stracci di disperazione fatti di osterie dove l’acquavite scorre a fiotti, di case bombardate e poi saccheggiate che le due letterature si incontrano.
Ágota Kristóf, però, si discosta chiaramente da questi suoi connazionali per la sua scelta, inusuale per un autore, di rinunciare alla scrittura nella sua madre lingua e di accogliere, invece, la nuova lingua acquisita nella terra d’esilio. Ágota Kristóf si rifugia in Svizzera, insieme a suo marito e a suo figlio neonato, nel 1956 in seguito alla repressione della controrivoluzione da parte dell’Unione sovietica. Ha 21, è ancora giovanissima, tuttavia non abbastanza per apprendere alla perfezione la nuova lingua. Ma ecco che, inaspettatamente, Ágota Kristóf riesce a fare di questa sua “imperfezione” linguistica, il tratto distintivo del suo stile letterario.
Uno stile asettico che si fa malinconico
Ci mettiamo a scrivere. Abbiamo due ore per trattare l’argomento e due fogli di carta a disposizione. […] Se è Bene, possiamo ricopiare il tema nel Grande Quaderno. Per decidere se è Bene o Non Bene, abbiamo una regola molto semplice: il tema deve essere vero. Dobbiamo descrivere ciò che vediamo, ciò che sentiamo, ciò che facciamo. […] Le parole che definiscono i sentimenti sono molto vaghe; è meglio evitare il loro impiego e attenersi alla descrizione degli oggetti, degli esseri umani e di se stessi, vale a dire alla descrizione fedele dei fatti.
– La trilogia della città di K.
Le particolarità de La trilogia della città di K. non si limitano alla composizione, ma si estendono all’ambito linguistico e di conseguenza allo stile.
Soprattutto la scrittura de Il grande quaderno è caratterizzata da uno stile scarno e che si potrebbe definire puerile. La narrazione è affidata ad uno dei gemelli che racconta quasi in presa diretta gli eventi e della scrittura di un bambino – o di qualcuno che padroneggia la lingua nei suoi tratti essenziali – ricalca i tratti. In questa sua scrittura dalle frasi semplici e brevi non c’è spazio per nessun abbellimento letterario, nessuna riflessione o commento, nessuna pillola per edulcorare la grama realtà.
La narrazione si trasforma in un dettagliato protocollo di ciò che accade. Una netta contrapposizione con lo stile lirico ed elegante di Marai, ma anche con i lunghissimi e monolitici blocchi id frasi di László Krasznahorkai.
Sennonché in questa esperienza di lettura, che è leggere La trilogia della città di K., succede una cosa strana.La distanza che il distacco tra autore e cosa scritta dovrebbe produrre nel lettore si annulla. Il lettore viene travolto in questo vortice di azioni, spesso surreali e violente, che si susseguono senza scampo, senza concedere respiro. L’effetto finale è di stordimento.
Ma poi arriva La terza prova a chiudere La trilogia della città di K., la scrittura si calma, assume la prima persona di un io adulto e diventa più riflettuta. Qui si fa più pressante la situazione dell’apolide, dello strappo dalla famiglia di origine e dalla propria patria e dell’esigenza di scriverne per chiudere un cerchio. È con quest’ultimo libro che allo stordimento si sostituisce la malinconia.
Scheda del libro La trilogia della città di K.
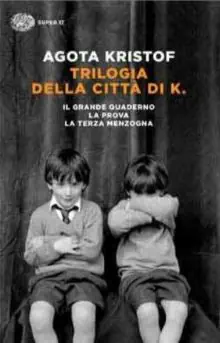
Titolo: La trilogia della città di K.
Autore: Ágota Kristóf
Casa editrice: Einaudi
Numero di pagine: 384
Traduzione di Armando Marchi, Virginia Ripa di Meana e Giovanni Bogliolo