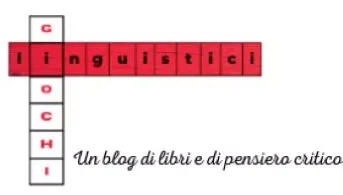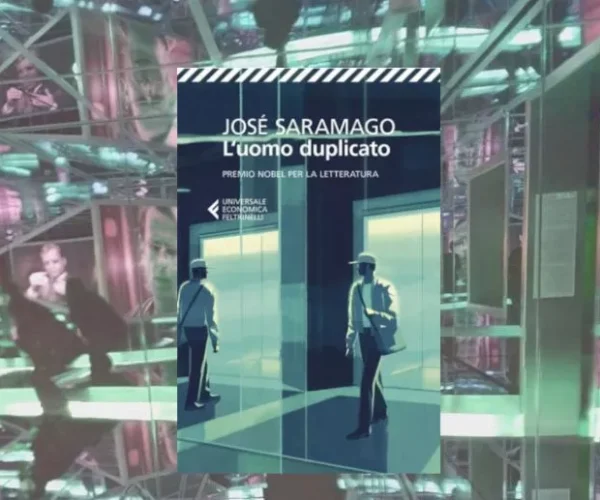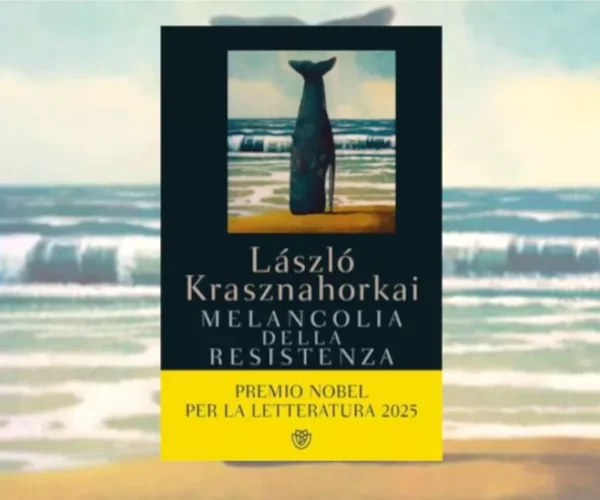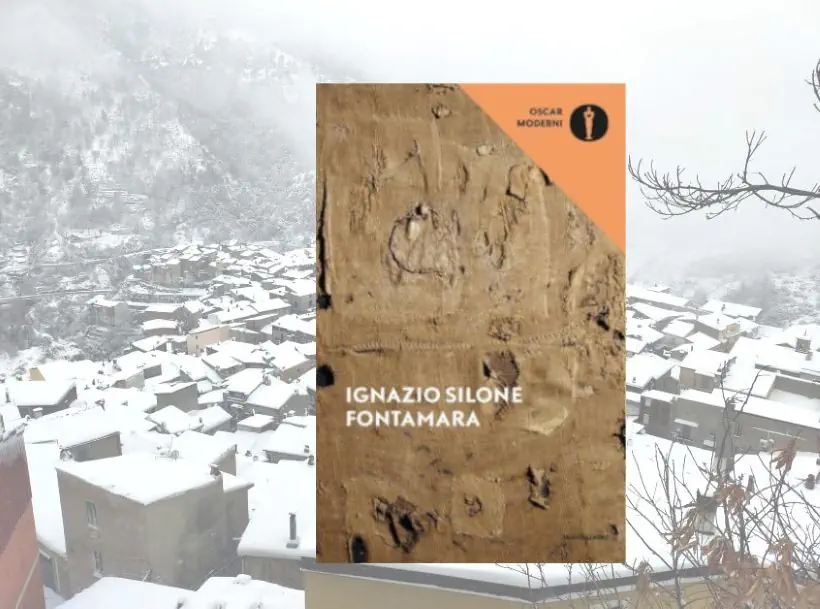
Dopo tante pene e tanti lutti, tante lacrime e tante piaghe, tanto odio, tante ingiustizie e tanta disperazione, che fare?
– Fontamara
Che fare? È la domanda di colui che ha perso ogni certezza. È il lamento di colui che non vede più nessuna via di uscita. È la disperazione che chiede sapendo di non avere la risposta.
Che fare? A queste due parole Ignazio Silone consegna il senso di disperazione che scorre, e non si esaurisce, lungo tutto il suo romanzo Fontamara. Forse è la domanda che si era posto lui stesso, allorché, perso tutto ciò che un uomo può perdere, famiglia, amici, il luogo natio si era rifugiato in terra straniera. Dal suo esilio in Svizzera, forzato dal soffocante e violento regime fascista in Italia, Ignazio Silone non smette di cercare una via per tendere una mano a quella sua patria bisognosa. Il suo contributo lo trova nella scrittura: da sempre la sua forza.
La voce degli oppressi che chiede di essere ascoltata diventa un romanzo, Fontamara, il suo messaggio è un amaro grido di denuncia. Ma a chi indirizzarlo? La prima ad accoglierlo quel grido fu la Svizzera ed in particolar modo la casa editrice Dr. Oprecht & Helbling AG di Zurigo che pubblica Fontamara in una traduzione in lingua tedesca, ma conservandone il titolo originale nel 1933. Poi Silone proverà a farlo pubblicare in versione originale ma, osteggiato in Italia per evidenti ragioni di censura fascista, si vide costretto ad assumere le spese di pubblicazione, che avverrà a Parigi, e ad usare una casa editrice fittizia, la Nuove edizioni italiane.
Ci vorrà la fine della guerra affinché la prima pubblicazione di Fontamara veda la luce in Italia. Corre l’anno 1947 e l’accoglienza è tiepida, i tempi non sembrano maturi per un’Italia impegnata a risorgere dalle proprie ceneri e dalle proprie colpe. Solo intorno agli anni ’60 i connazionali saranno in grado di vedere apprezzare il genio letterario di Ignazio Silone.
Trama – 1929 Marsica (Abruzzo), la dittatura fascista ha posato il suo drappo di morte sulla penisola da qualche anno, ma gli abitanti di Fontamara, isolati sulle montagne, non sembrano accorgersene. Almeno fino a quando le loro già precarissime condizioni di vita si inaspriscono ancora di più. Quelle montagne che li isolano non si può dire che assumano anche il ruolo di ergersi a loro protettrici. Al contrario, l’asprezza del terreno poco fertile e sassoso genera per i pochi piccoli possidenti terrieri un raccolto così esiguo da costringerli a lavorare anche a giornate per pagare i debiti. Ma non fanno da scudo nemmeno dalle ingerenze del mondo esterno che si abbattono inaspettatamente e violentemente sui poveri abitanti di Fontamara.
La prima ingiustizia i fontamaresi la subiscono quando viene loro tagliata la luce elettrica in seguito a delle tasse non pagate. La seconda, oltre che un’ingiustizia, è un vero e proprio inganno. Il corso di un piccolo ruscello, la loro unica fonte d’acqua per irrigare la terra, viene deviato a vantaggio di un ricco possidente terriero. Quando le donne di Fontamara si recano in paese per protestare scoprono che al sindaco si è sostituito il podestà. E proprio quest’ultimo è il ricco possidente, detto l’impresario, che usufruirà della loro acqua.
È subito chiaro che nonostante la loro ribellione, i tentativi, più o meno pacifici, i paesani niente possono contro la corruzione dei potenti. I vecchi e i nuovi usurpatori, clero compreso, in un’escalation di soprusi affamano, terrorizzano, e si prendono continuamente gioco dell’ingenuità, e dell’impotenza, dei poveri. Da questa moltitudine indistinta di sofferenze accomunate da una sorte che porta il nome di cafoni, emerge poi la figura di Berardo Viola, vittima tra le vittime che nonostante il duro lavoro e la determinazione nulla può contro l’amaro destino.
La deumanizzazione degli oppressi
«E noi?» gli rispondemmo. «Non siamo cristiani anche noi?»
«Voi siete cafone» ci rispose quello. «Carne abituata a soffrire.»
Fontamara è, lo abbiamo già accennato, il grido di denuncia dei cafoni, di quelli che nelle odiose scale sociali stanno al gradino più basso di tutti. A loro appartiene la storia e, di conseguenza, loro è la voce narrante. Silone racconta, perciò, attraverso tre personaggi, una famiglia composta da tre cafoni: madre, padre e figlio che si succedono nell’assumere l’io narrativo.
Per rendere ancora più realistico il drammatico trascinarsi quotidiano, Silone usa una lingua che non è propriamente un dialetto, ma che a quest’ultimo molto si avvicina. Ne viene fuori una lingua parlata, cruda, primordiale, senza orpelli, e non esente dal creare nel lettore una certa ilarità dovuta appunto all’ingenuità dei cafoni. È questa ilarità, abbondantemente presente nella prima parte del romanzo, che rende la durezza più sopportabile per il lettore.
Attraverso la rusticità del suo stile e gli stessi eventi narrati, Ignazio Silone non solo mostra la fatica, la sofferenza e le pene degli oppressi, ma ne mette a nudo anche il sistema che genera tali iniquità. Certo il sistema è profondamente corrotto, sbilanciato in una lotta di uomo contro uomo, in cui il pesce grande, mangia il piccolo. E come se non bastasse, c’è l’ignoranza dei cafoni, la loro mancanza di conoscenza – come, ad esempio, il non sapere a quanti anni corrisponde un lustro – a renderli facilmente ingannabili.
Da questa deriva anche la loro mancanza di autonomia che li costringe ad affidarsi alle persone sbagliate come l’avvocato Don Circostanza, il quale non perde occasione per raggirarli a suo vantaggio invece di aiutarli.
Ma al di là di questi motivi, Ignazio Silone indaga, in una chiava che è possibile definire di natura filosofica-antropologica, come la loro mala sorte sia legata al fatto che i cafoni non sono percepiti umanamente ed empaticamente sullo stesso piano degli altri uomini e donne. Il carabiniere interrogato dalla donna di Fontamara risponde che quella dei cafoni è una carne “abituata a soffrire”. Come se ci fosse un più umano e un meno umano, come se la sofferenza fosse più o meno sopportabile a seconda del soggetto a cui “tocca in sorte”. E come se dovesse toccare ad alcuni ma non ad altri.
A questa forma di empatia selettiva, che necessita di essere scossa nel suo fondamento, si rivolgono i poveri cafoni, e Silone con loro, chiedendogli “cosa fare?”.
Scheda del libro Fontamara
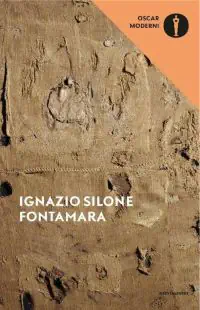
Titolo: Fontamara
Autore: Ignazio Silone
Edizione italiana: Oscar Mondadori
Anno di pubblicazione: 2016
Numero di pagine: 166
Potrebbe interessarvi anche la recensione di Bebelplatz