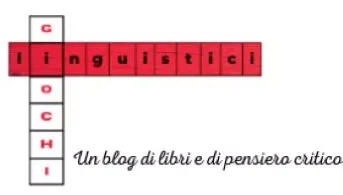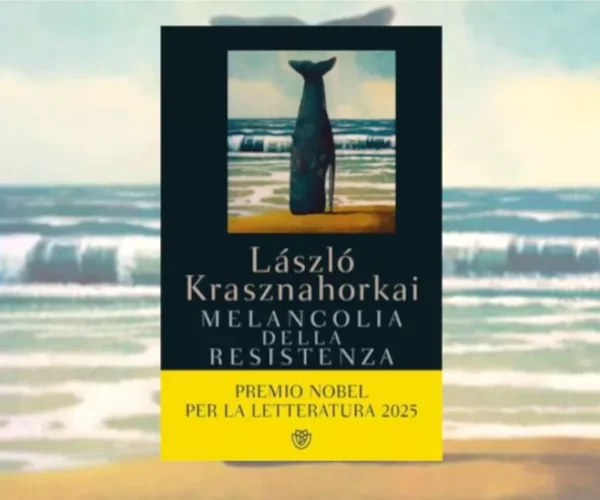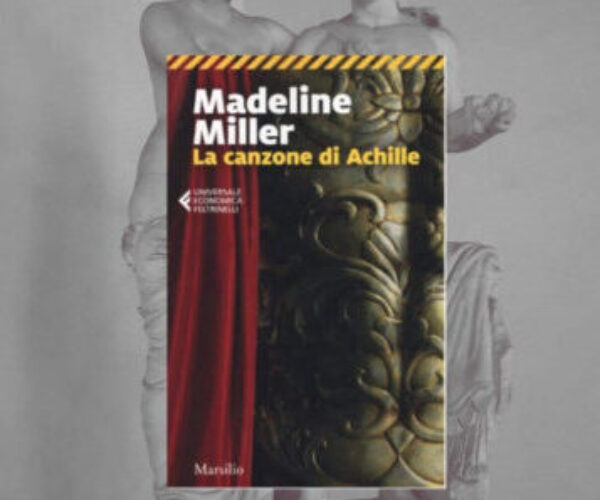Una nostalgica storia di classi sociali della Mitteleuropa al suo tramonto, camuffata da un triangolo amoroso che forse diventa un quadrilatero: così mi verrebbe da riassumere questo capolavoro incompreso, o per lo meno troppo trascurato al suo tempo, che è La donna giusta di Sándor Márai. Un classico, un romanzo maturo capace di fare luce sugli aspetti più inesplorati nei legami sentimentali e nell’altrettanto difficile rapporto con la propria patria.
Trama de La donna giusta – In un’elegante pasticcieria della Budapest degli anni ’40, Marika, una donna sola e disillusa dalla vita, racconta ad una sua amica della fine del suo matrimonio. Marika ha appena intravisto per caso il suo ex-marito e dalla sua reazione commossa si intuisce che il racconto sarà velato d una nota di struggente sentimentalismo.
Il monologo di Marika, però, pur essendo ancora connotato dal dolore della donna ferita, apre ad lucida riflessione non solo sullo spaccato della vita matrimoniale con Peter, un industriale dell’alta borghesia, ma più in generale accenna ad un problema, che poi sarà sviluppato, su come le sue pene d’amore derivino dalla loro classe sociale di appartenenza: la borghesia.
Marika, proveniente da una famiglia della piccola borghesia, racconta i suoi sforzi per far funzionare il matrimonio con Peter. Il loro, tuttavia, sembra un matrimonio destinato a fallire proprio a causa dell’incapacità di Peter di amare Marika. Dopo innumerevoli tentativi e interrogativi – in cui Marika cerca di comprendere il marito, figura da lei idealizzata – la donna era giunta ad un’amara verità: il posto nel cuore di suo marito era già occupato da un’altra donna che si rivelerà essere la governante della madre di Peter. Judit è, per l’appunto, la donna giusta.
Nella seconda parte del libro è proprio Peter a prendere il testimone della narrazione. In una scena che replica la prima, Peter, ormai un signore decaduto, racconta ad un amico dei suoi due matrimoni falliti. L’ambientazione è un bar di Budapest, l’eleganza del primo viene annacquata dall’alcool che il duetto consuma abbondantemente. Al centro del suo racconto non c’è Marika, donna rispettata ma mai amata proprio per il suo essere “borghese”. No, la donna giusta, come Marika aveva ben intuito, era stata Judit. Lo era stata finché anche quest’unione, non si era rivelata nient’altro che un’illusione.
A distanza di anni la scena narrativa si sposta da Budapest a Roma. Qui, in una camera d’albergo che da su Via Liguria, troviamo Judit in compagnia del suo giovane amante, un batterista suo connazionale. A lui si rivolge Judit nel corso del suo monologo. Ispirata dal ritrovamento di una foto del suo ex marito, ripercorre non solo la sua storia con Peter, ma anche la sua vita, compresa la sua ascesa sociale da serva a signora.
Un epilogo affidato al batterista va, poi, a chiudere un cerchio di una storia di amore, forse, ma soprattutto dell’eclissi di una classe sociale, come l’ha conosciuta, a suo tempo, Sándor Márai.

Il titolo La donna giusta
Questa volta vorrei iniziare dal principio e in principio era… il verbo? No, il titolo. Sebbene abitualmente non mi soffermi sulla corrispondenza tra contenuto del libro e titolo, questa volta la fuorvianza mi sembra tale da meritare una nota a riguardo per meglio comprendere il romanzo. La donna giusta è un titolo fuorviante per diverse ragioni, innanzitutto strutturali.
Il romanzo di Márai è costituito, come dicevo, da 4 parti. Queste 4 componenti racchiudono una storia editoriale alquanto particolare che giustifica la considerevole differenza stilistica e di tono delle stesse.
Le prime due parti sono, per un criterio estetico “oggettivo”, le più belle e stilisticamente armoniose. Simili tra loro, sono entrambe ambientate a Budapest in un arco temporale piuttosto ristretto e precedente alla Seconda guerra mondiale. La somiglianza fra queste due non sono un caso, esse fanno parte di un primo progetto comune. Vennero, infatti, scritte da Márai nel 1941 e pubblicate con il titolo di Az igazi indicando un più generico e neutro La persona giusta.
La donna giusta fu, poi, pubblicato in lingua tedesca nel 1949 con il titolo Wandlungen der Ehe (Metamorfosi di un matrimonio). In occasione della pubblicazione in Germania, Márai aggiunse un ulteriore capitolo, il monologo di Judit.
Ai 3 monologhi si aggiunse poi un epilogo finale, quello del batterista, per l’edizione americana del libro pubblicato nel 1980. Quest’edizione finale porta il titolo Portraits of a marriage (Ritratti di un matrimonio). Per alcuni aspetti più calzante del titolo italiano. Anche se le due seconde parti, in particolare la seconda, sembrano ormai uscire dal progetto iniziale di una riflessione sul sentimento dell’amore coniugale e sulla ricerca illusoria della persona giusta. La direzione che prendono i due ultimi monologhi è più propriamente politica, lo stile si fa meno lirico e maggiormente disconnesso, riflettendo, in fondo, il turbamento interiore dell’autore.
La figura emblematica di Lázár e sul concetto di patria
Complice la stesura dei monologhi in anni diversi, la narrazione de La donna giusta ha una struttura a macchia d’olio, che parte da un punto preciso e si espande. La prima goccia precisa e circoscritta è davvero la questione amorosa della donna giusta e della conseguente disillusione dei personaggi.
Ma man mano che i cerchi concentrici si fanno più ampi, sembra, sempre più, che Márai stia parlando di concetti più generi come quello delle relazioni all’interno della classe sociale borghese, e tra le classi, fino ad arrivare alla questione del concetto di patria.
È la figura dello scrittore, prima, del batterista, dopo, a dare la possibilità all’autore di riflettere su questo concetto. Certo i due rappresentano entrambi due approcci molto diversi alla vita, ma entrambi di fronte al lutto della perdita della patria, cercano un ripensamento di questo concetto. Il batterista, che è esule prima a Roma e poi in America ha la possibilità di costatare l’inganno dietro al sogno americano, esprime così il suo nostalgico sentimento:
L’odore della terra bagnata, mi ha accompagnato fino al confine, come se quella fosse l’unica cosa che mi restava della patria.
– La donna giusta
Il discorso con lo scrittore Lázár è più complesso. Pur non avendo la sua propria voce che dice “io” in uno dei monologhi, Lázár è una figura chiave de La donna giusta: è il testimone silente che conserva la memoria culturale della sua epoca. Per molti aspetti Lázár è lo stesso Márai. Come Lázár, l’autore si rinchiude in una reclusione volontaria durante la Seconda guerra mondiale. Come lui, trascorre un periodo di esilio in Italia. Ma soprattutto, come Lázár, Márai si interroga sul ruolo dello scrittore. Su che senso abbia ancora scrivere, durante l’esperienza terrificante e distruttiva della guerra, che ha spazzato via l’ultimo barlume di fiducia nell’umanità.
Le sue riflessioni sul delicato ruolo della borghesia come preservatrice della cultura, che lui ha conosciuto in ragione della sua appartenenza ad essa, diventa un discorso sul senso di conservare un sentimento di appartenenza verso qualcosa che non esiste più, non solo la classe borghese ma, piuttosto, la stessa patria. Ma se la patria come entità geografica e culturale come la conosceva Márai si è dissolta, c’è pur sempre un resto. Questo resto per lo scrittore, e per Márai, sembra essere la lingua. Lázár lo afferma, così come lo aveva affermato il generale, protagonista de Le braci, nel suo monologo: “L’ungherese è la patria”.
Scheda del libro La donna giusta

Autore: Sándor Márai
Titolo: La donna giusta
Anno della prima pubblicazione in Italia: 2004
Casa editrice: Adelphi
Numero di pagine: 444
Traduzione di Laura Sgarioto, Krisztina Sàndor
Potrebbe interessarvi anche la recensione de La coscienza di Zeno di Italo Svevo