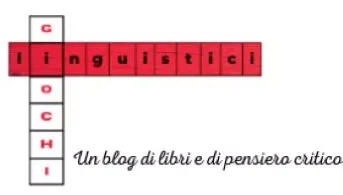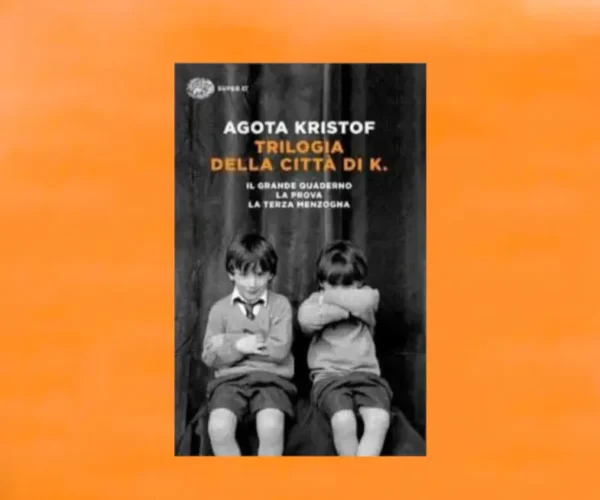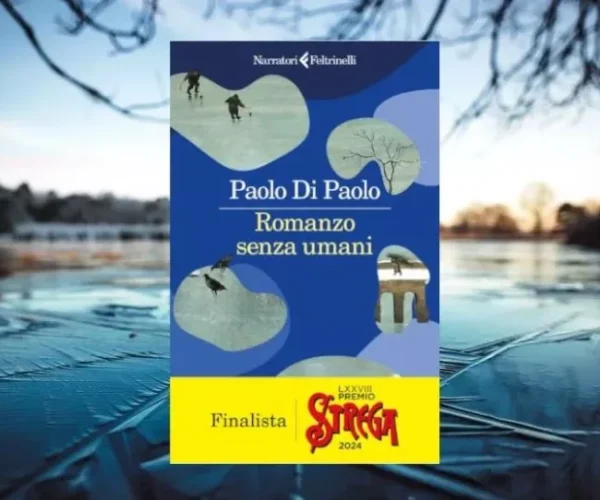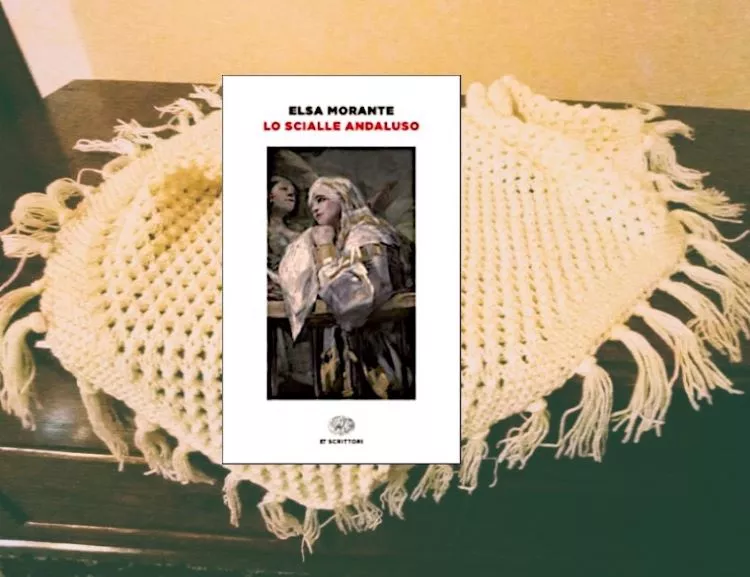
Sebbene io non abbia ancora vissuto un numero d’anni sufficiente per poterlo credere, sono quasi certa di essere stata io, quella ragazzina.
– Incipit de Il ladro dei lumi. Lo scialle Andaluso
Che Elsa Morante fu una grande romanziera è risaputo. La storia, Menzogna e sortilegio, L’isola di Arturo sono i suoi romanzi più conosciuti ed amati, eppure, questi tre colossi della letteratura italiana non sono che una parte della sua ampia produzione letteraria. Sono soprattutto i tanti racconti – nonché fiabe e filastrocche per bambini –, pubblicati su diverse riviste tra le quali Il corriere dei Piccoli, ad infittire il paesaggio letterario morantiano.
Due sono le variabili che le permisero di lasciare una così vasta mole di opere. Primo, Elsa Morante iniziò a scrivere fin da ragazzina. Secondo, la scrittura fu per lei uno strumento per raggiungere l’indipendenza economica – e, per una donna ai suoi tempi, l’emancipazione tout court –. A queste due variabili – scritti giovanili e scritti per sbarcare il lunario – si ascrivono i racconti che compongono Lo scialle andaluso. Una raccolta, in ordine cronologico, di racconti appartenenti “alla preistoria dell’autrice” – come lei stessa afferma –, alcuni già pubblicati per altre riviste come L’europeo e Botteghe oscure, altri inediti.
La raccolta Lo scialle andaluso porta con sé una grande occasione, per i lettori, ossia quella di poter ricostruire, attraverso i suoi magnifici racconti, la genesi di una delle più grandi scrittrici italiane del Novecento.
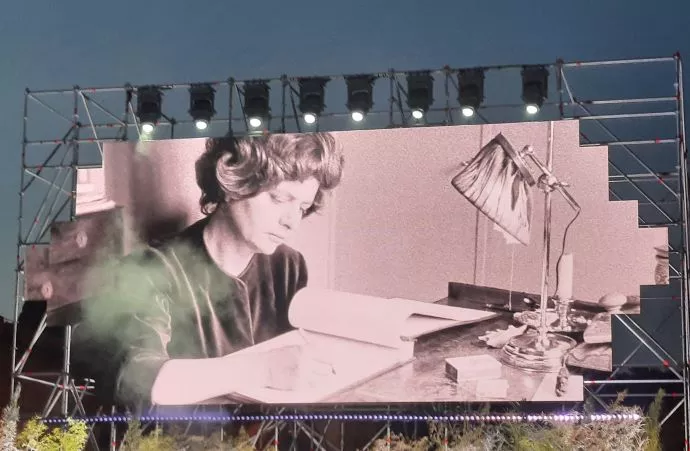
I racconti, un filo comune
Raccontare la trama de Lo scialle andaluso si rivela alquanto complicato, a causa della stessa natura del libro, si tratta, infatti, – come già detto – di una serie di racconti. I racconti, come è normale, a loro volta comprendono al loro interno ognuno una trama, un universo a sé. Ma se è vero che ognuno di essi racconta la propria storia, non è del tutto corretto, definirli slegati l’uno dall’altro. I punti di intersezione sono tanti, partendo innanzitutto dalla riconoscibilità dello stile, aggiungendoci poi la ben conosciuta dimensione magico-mitica alla Morante.
Anche nella descrizione dei personaggi – soprattutto nella mancaza di indulgenza con cui descrive le donne – e nelle relazioni che intercorrono fra di loro è possibile rintracciare uno filo conduttore che unisce le varie narrazioni. Ma il vero elemento comune, un collant intangibile eppure mastodontico, è la pesantezza dell’atmosfera. Tutti i personaggi, di tutti racconti, sono alle prese con la sofferenza del vivere. Una sofferenza tanto umana quanto fatalistica che dal personaggio più giovane a quello più vecchio, indipendentemente dalle condizioni che l’hanno causata, non risparmia nessuno.
12 racconti contro uno
Un ottimo vademecum per leggere i racconti è offerto dalla nota finale della stessa autrice. In questa Elsa Morante svela l’officina letteraria dietro alla scrittura. Vi lascio al piacere della sua lettura.
I primi racconti – Il ladro dei lumi, L’uomo dagli occhiali, La nonna, Via dell’Angelo, Il gioco segreto, Il compagno, La giornata, Il battesimo, Il cugino Venanzio, Un uomo senza carattere, Il soldato siciliano, Donna Amalia – sono stati scritti tutti, tranne Donna Amalia, prima del 1948. Un’estrema brevità li caratterizza, molti contano, infatti, appena qualche pagina.
Chiamarli racconti minori, rispetto a Lo scialle andaluso – l’ultimo racconto ma insieme il centro propulsore del libro che tra l’altro gli dà anche il titolo – non vuole essere uno sminuire la bellezza stilistica che, eppure, è presente in tutti. Nonostante ciò va detto che se gli altri racconti hanno un qualcosa di frammentario – nel senso di lacunoso, perché non approfondito – Lo scialle andaluso è più simile ad una novella. Completa e perfetta e – qui è ancora una volta la nota a venirci in soccorso – contemporanea alla scrittura de L’isola di Arturo. E le similitudini tra le due opere, infatti, non passano inosservate.
Lo scialle andaluso trama
Lo scialle Andaluso racconta la storia di Giuditta. Una ragazza siciliana con la passione per il teatro che lascia la sua terra d’origine e si trasferisce a Roma guidata dall’ambizione di diventare una famosa prima ballerina. A Roma Giuditta diventa, prima, moglie e madre di due gemelli Laura e Andrea e, subito dopo, vedova. Le difficoltà di dover crescere da sola i due bambini non le fanno, però, perdere di vista il suo sogno di diventare una famosa stella del teatro. Nonostante la forte aspirazione, Giuditta non è particolarmente talentuosa, lavora, perciò, come ballerina semplice del corpo di ballo del Teatro d’Opera. Un antagonista ai sogni di gloria di Giuditta si rivela essere proprio il figlio, Andrea.
Quest’ultimo ama la madre di un amore totalizzante e odia con altrettanta intensità il teatro che gli sottrae parte delle attenzioni materne. Le assenze della madre lo fanno soffrire a tal punto che Andrea, divenuto ormai un ragazzo, decide di allontanarsi da Giuditta e di votarsi ad una vita ascetica tra le mura di un convento.
I due si ritroveranno poi a distanza di qualche anno, quando ormai la carriera di Giuditta è più che mai in declino. Sarà allora che Giuditta potrà dedicarsi all’amore incondizionato del suo Andrea, alla maniera delle mamme siciliane che si annullano nei loro figli.
Lo scialle andaluso, indossato da Andrea, la sera della riappacificazione rimarrà il simbolo di un momento fugace e perfetto di pieno amore tra madre e figlio. L’ultimo velamento prima della rivelazione.
Rapporto madre-figlio
Il rapporto tra Giuditta ed Andrea è basato su dinamiche simili a quelle tra Wilhelm e Arturo (padre e figlio), ma se ne L’isola di Arturo questo si presenta come unidirezionale, qui ci troviamo di fronte ad un caso di rapporto speculare tra madre e figlio. Il figlio venera la madre, ma anche la madre miticizza il figlio. Tanto che alla fine si trasforma in una mamma “siciliana”. Ma anche durante tutta la novella Giuditta si riferisce al figlio usando sempre degli appellativi mitici che dimostrano l’adorazione della madre.
Proprio la sfera degli epiteti e dei nomignoli rivela, inoltre, un’altra affinità con L’isola di Arturo. Mentre in quest’ultimo romanzo il termine Parodia, viene usato come dispregiativo per riferirsi al padre di Arturo, ne Lo scialle Andaluso sono, in maniera parallela, le cattiverie rivolte alla madre durante e dopo lo spettacolo a rivestire la stessa funzione: far crollare il velo del mito e mostrare la realtà per quello che è.
Egli arrivò a convincersi che sua madre non solo non era mai stata la famosa artista che lui bambino immaginava, ma non era stata neppure un’artista incompresa, e neppure un’artista. […] A questo punto, si presentarono alla memoria di Andrea le parole maligne udite quella sera là in teatro, nel corridoio dei camerini. Egli le aveva udite allora quelle parole; ma, come soldati che preparano un’imboscata, appena udite, esse eran corse a rifugiarsi in un nascondiglio della sua mente, donde riapparvero, per assalirlo d’improvviso. Andrea le riudì, una per una, e imparò ch’esse riguardavano sua madre. Erano parole odiose, nemiche crudeli da cui voleva difendersi; ma alla fine mentivano?
Andrea Campese si rivela, in ultima istanza, un Arturo Gerace minore, meno tratteggiato, meno avventuriero e anche meno amabile, se vogliamo, ma i germogli del grande protagonista sono già tutti qui.
Scheda del libro
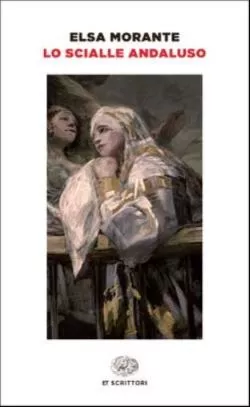
Titolo: Lo scialle andaluso
Autore: Elsa Morante
Anno di pubblicazione: 1963
Casa editrice: Einaudi
Numero di Pagine: 224