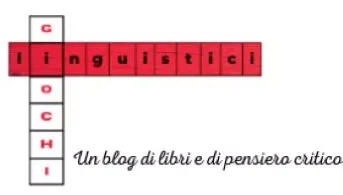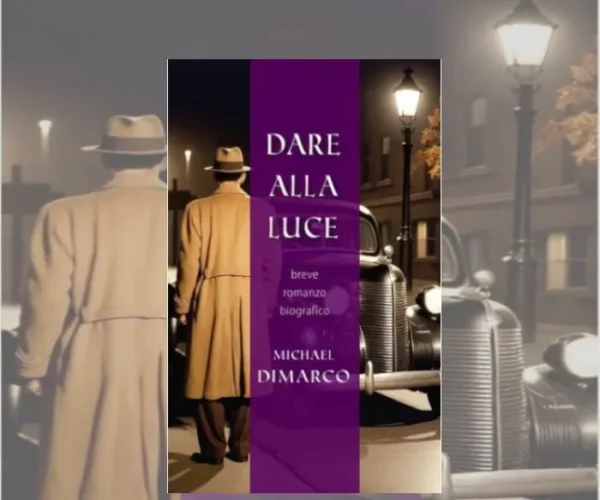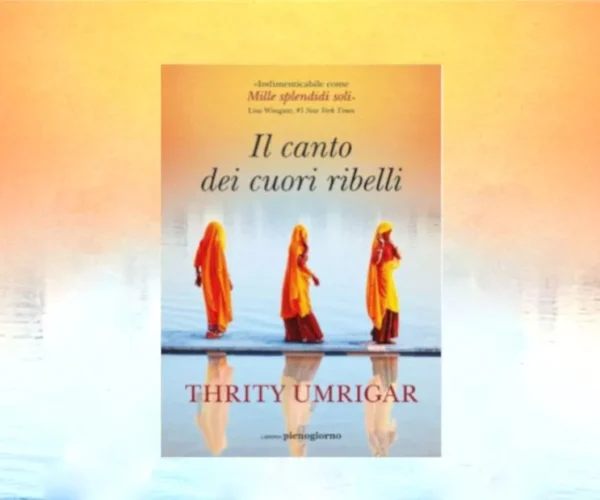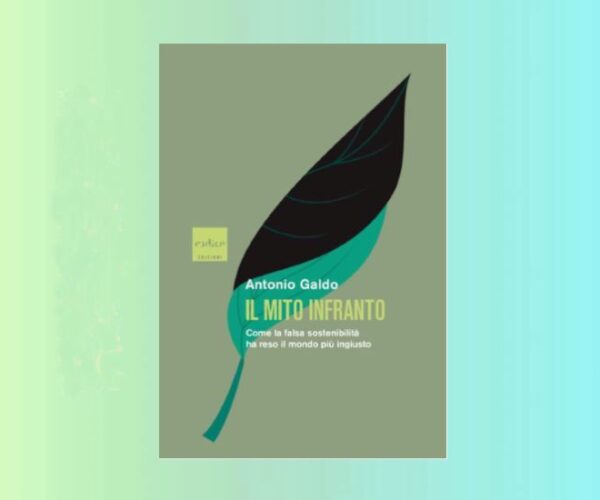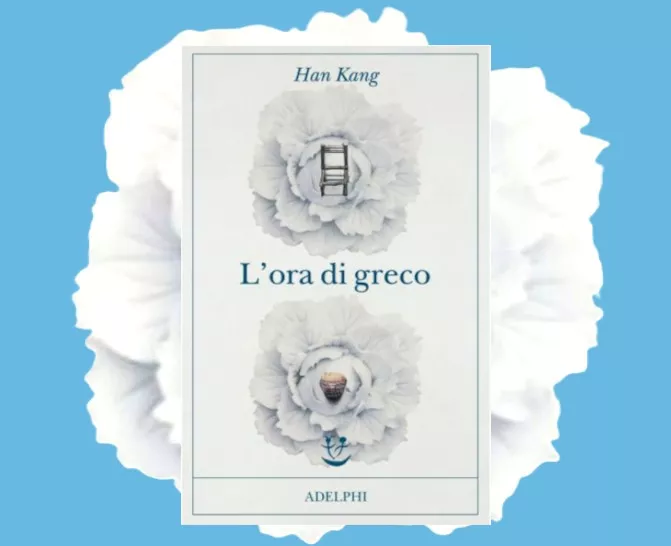
C’è una spada tra i protagonisti di questa storia e il mondo. Una spada invisibile, ma abbastanza affilata da recidere la loro connessione con il mondo, lasciandoli nello stordimento di uno stato liminare dell’esperibile umano. I personaggi, entrambi senza nome, si ritrovano ad esperire la realtà che li circonda partendo da una privazione sensoriale. Per la protagonista femminile de L’ora di greco, si tratta di un mutismo che sembra coinvolgere anche la stessa capacità di percepire la connessione tra linguaggio e cose. Per il protagonista maschile, è la graduale perdita della vista ad imporre delle barriere. In entrambi i casi, come nella migliore tradizione filosofica coreana, la privazione sa farsi vuoto ascetico.
Trama – La donna e l’uomo si incontrano durante l’ora di greco, per l’appunto. Lei è l’allieva, una donna “non più giovane, non particolarmente bella” che veste di nero in segno di lutto per la perdita della madre. Accanto a questo lutto un’altra perdita la tiene in scacco, il figlio di sette anni è stato affidato al padre e lei può vederlo solo ogni due settimane. L’improvviso mutismo è una conseguenza di questi traumi, sennonché nel suo passato si era già verificato un episodio del genere.
All’epoca l’evento decisivo capace di sbloccarlo era stato l’ascolto di un termine francese. Ora, spera che sia il greco, questa lingua desueta eppure all’apice della civiltà umana, a farle ritrovare il varco tra le sue corde vocali e il mondo.
L’uomo è il professore di greco. Un uomo sulla quarantina che ha vissuto quasi metà della sua vita in Germania, dove era emigrato con la famiglia. Pur essendo rientrato a Seul da qualche anno, l’uomo vive ancora in questa cesura tra le due culture. Anche se la più grande cesura nella sua vita è quella che va producendosi di giorno in giorno tra un prima fatto di una vita animata e a colori e un dopo fatto di oscurità. L’uomo sta infatti perdendo la vista e per questo preferisce rifugiarsi nella memoria del prima, delle cose che conosce e in cui si sente al sicuro.
In questo tentativo di allacciare passato e presente, Germania e Corea, l’uomo scrive delle lettere alle persone care che vivono in Germania.
Entrambi sono due solitudini, due nomadi chiuse nel loro mondo, perciò, il loro incontro è destinato a diventare un delicato sfiorarsi di anime.
L’esperienza linguistica e la sua assenza
Han Kang affida a L’ora di greco le sue riflessioni sul linguaggio, sulla sua bellezza e sulla sua artificiosità, e lo fa, soprattutto, sfruttando l’esperienza linguistica della protagonista femminile. La protagonista che nei suoi ricordi di bambina apprende, dapprima, con una vertigine di stupore e meraviglia la corrispondenza tra i grafemi, fonemi e cosa esistente, ne è poi stordita a causa dell’intensificazione ossessiva della sua esperienza con i segni linguistici.
È come se nelle sue riflessioni metalinguistiche il velo si scoprisse per un momento, lasciandole percepire il linguaggio come un inganno e “allora le veniva da gridare” – scrive Han Kang – forse per ristabilire un ordine naturale ed immediato con la materialità fonetica, un ordine senza l’imperfezione del significato e privo dello scarto tra suono e grafema. Ma poi anche il grido si spegne e arriva il silenzio a liberarla dalla prigione del linguaggio, riempiendola di quiete. Senonché l’atrofia linguistica, in questo suo secondo mutismo, perde il suo lato positivo e diventa piuttosto una morte, un farsi ancora più piccola per non occupare spazio, un annullarsi.
Ma la cosa più penosa di tutte era che sentiva con una chiarezza agghiacciante ogni singola parola che le usciva di bocca. Perfino la frase più banale lasciava intravedere con la trasparenza del cristallo perfezioni e imperfezioni, verità e inganno, bellezza e bruttezza. Lei si vergognava di quelle frasi, che si dipanavano bianche come ragnatele dalle sue mani e dalla sua lingua. Le veniva da vomitare. Le veniva da gridare.
E alla fine, un inverno, era arrivata quella cosa. Aveva appena compiuto sedici anni quando, di colpo, il linguaggio che l’aveva imprigionata e torturata come un vestito intessuto di migliaia di spilli era sparito.
[…] Questo silenzio tornato dopo vent’anni non ha né il tepore, né la densità, né la luminosità del primo. Se in passato faceva pensare al silenzio che precede la nascita, ora assomiglia di più a quello che segue la morte.
– L’ora di greco
Per inciso, un’altra autrice era riuscita a rendere altrettanto meravigliosamente l’esperienza linguistica dello svelamento dell’inganno, mi riferisco a Ingeborg Bachmann, in particolar modo nel primo racconto Simultaneo dell’opera Tre sentieri per il lago, sebbene tutta la sua opera ne sia pervasa.
Per quanto riguarda l’esperienza linguistica dell’uomo, questa si scontra non con il silenzio ma con il plurilinguismo. Diviso culturalmente tra Corea e Germania dove ha vissuto dai 14 anni in poi, allorché si avvia verso la perdita definitiva della vista sceglie la sua madre lingua, il coreano, come rifugio. Così come aveva scelto il greco, lingua che insegna, all’epoca dei suoi studi. Una lingua morta in cui gli sembra di potersi orientare meglio.
Ma il greco ha anche un’altra funzione nell’ecosistema del testo: è il ponte che permette all’autrice di avvicinare la filosofia occidentale a quella orientale. Durante le lezioni, infatti, insieme alle regole grammaticali e sintattiche il professore introduce anche il pensiero dei maggiori filosofici greci, imprescindibili dalla propria lingua.
Il greco utilizzato da Platone assomiglia a un frutto maturo sul punto di cadere dal ramo. Nelle generazioni successive, conoscerà una rapida decadenza. Non solo la lingua, anche le città-stato andranno incontro al declino. In questo senso, potremmo dire che Platone aveva di fronte a sé il tramonto non solo della sua lingua, ma di tutto il suo mondo.
– L’ora di greco
Qualcosa sfugge
Han Kang può dare l’impressione di essere un’autrice che pone delle distanze, difficile da avvicinare, e i suoi testi, soprattutto L’ora di greco, enigmatici e rarefatti. Sicuramente lo sono, ma quest’impressione l’avrà maggiormente il lettore italiano abituato all’estroversione dei nostri modi. Han Kang è figlia della sua cultura coreana, impregnata di una filosofia ascetica che dà più peso alla quiete del vuoto che all’esuberanza del pieno, più all’interiorità che all’esteriorità.
Perciò il silenzio della protagonista è molto più comprensibile nella prospettiva di una cultura volta alla ritrosia, che non nella nostra. In quest’ottica, seppur mai completamente comprensibile, la privazione è in linea con quell’annullarsi, quel ridursi a pianta che conosciamo così bene dal suo libro La Vegetariana.
Scheda del libro L’ora di greco di Han Kang
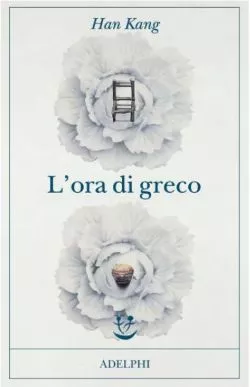
Autore: Han Kang
Titolo: L’ora di greco
Casa Editrice: Adelphi, Milano
Anno di pubblicazione: 2023
Numero di pagine: 163
Traduzione di Lia Iovenitti
Della stessa autrice potrebbe interessarvi anche la recensione di Atti umani e di Convalescenza