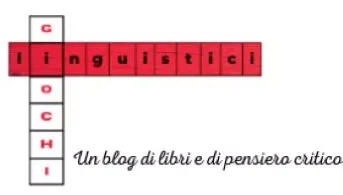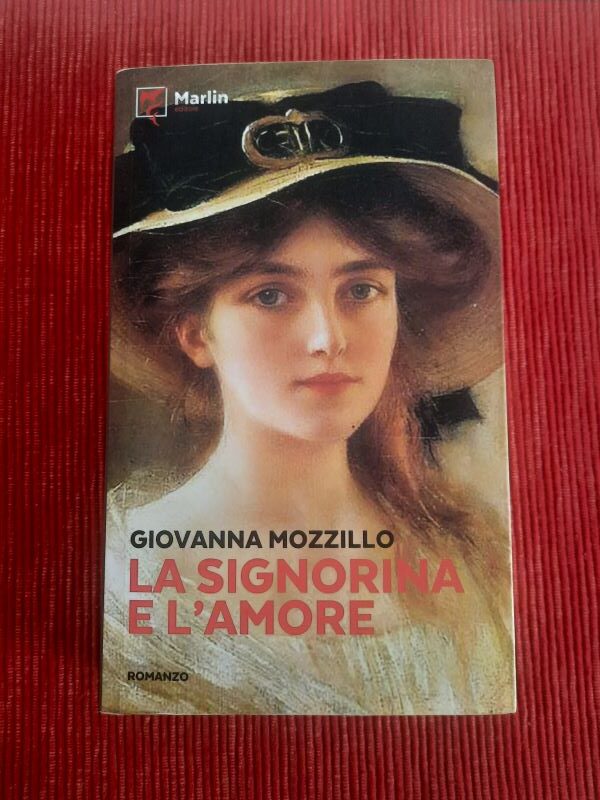
Trama – Rosella è una giovane e romantica ragazza della borghesia napoletana del ventennio Fascista. Dotata di grande sensibilità, vive la sua vita tra gli agi con spensieratezza ma senza arroganza. Pur rimanendo una ragazza obbediente, va crescendo dentro di lei un senso di repulsione per alcune convenzioni e ingiustizie sociali tipiche della borghese. Nella sua riservatezza sogna come tutte le ragazze (o forse ancor più delle altre) l’amore. Lo attende con trepidazione e sa che quando arriverà amerà senza remore. Quando finalmente il grande amore arriva Rosella ha 23 anni e l’uomo che le farà battere il cuore è un affermato dottore di 32 anni, il quale ahimè è già sposato. Sebbene non sia il tipo di amore che Rosella aveva sognato, e nonostante nutra delle riserve per quest’unione che esula dalla sua morale, si farà portatrice del suo destino e assumerà come sua missione restare vicino a quest’uomo ambizioso e dallo sguardo sornione, ma allo stesso tempo fragile e puro come un bambino.
Romanzo storico borghese
Oltre che un romanzo d’amore, La signorina e l’amore è sicuramente un romanzo storico. Il lettore si ritrova immerso nella Napoli fra il 1925 e il 1942. La narrazione in terza persona si concentra sul punto di vista della protagonista e guarda gli eventi, gli altri personaggi e la città di Napoli attraverso i suoi occhi. Attraverso la sua storia percepiamo i modi di vivere e le credenze della borghesia. Una borghesia arrogante, signora e padrona, che esige il rispetto del ceto meno abbiente. Ne emerge un quadro storico di forte polarizzazione delle classi sociali fra padrona e serva, signore e pezzente, e un disprezzo per tutto ciò che è non convenzionale, compresa l’omosessualità. Atteggiamento che andrà scemando fino allo scoppio della guerra, durante la quale la borghesia conserverà sì qualche privilegio, ma drasticamente ridotti perché si sa: sotto i bombardamenti e le brutture della guerra siamo tutti uguali.
La Storia
Il Fascismo costituisce un po’ un filo conduttore sullo sfondo, che in un crescendo, dal ’25 al ’42, emerge sempre più in primo piano. All’inizio percepiamo come una voce indistinta, un tema di discussione come un altro tra Teresa, la sorella di Rosella, e zio Riri. La successione dei deputati sull’Aventino e l’ascesa al potere dei fascisti è accolta da molti borghesi come un “toccasana” per il Paese, ormai abbindolati dai sogni di gloria e dalla promessa dell’impero. Teresa, invece, come la maggior parte degli intellettuali, è diffidente e aborrisce la violenza fascista. Rosella ha posizioni meno nette, inizialmente assisterà alla visita del Führer a Napoli senza avere una propria opinione, piano piano quando le leggi razziali colpiranno un’amica e la guerra diventerà la dura realtà con cui tutto il popolo napoletano è costretto a confrontarsi giorno per giorno, sarà troppo tardi per opporsi. Il Fascismo sarà già diventato l’antagonista principale alla storia di amore fra Rosella e Leonardo.
I personaggi in La signorina e l’Amore
Con lo svilupparsi delle vicende assistiamo ad un’evoluzione del personaggio principale. Da fanciulla ingenua e di fragile costituzione, Rosella diventerà una donna forte, energica e risoluta. Accanto a Rosella e Leonardo c’è una schiera di personaggi, tutti accumunati dal fatto di ruotare in qualche modo attorno all’universo di Rosella. Alcuni minori, svolgono la funzione di aiutanti del personaggio principali, altri di maggiore spessore apportano con le proprie storie di vissuto degli ulteriori, significativi tasselli nel definire i costumi dell’educazione sentimentale di quell’epoca storica. In questo affresco corale spiccano le micro-narrazioni di Pipina (zia di Rosella) e della sua storia d’amore incompiuto, così come la vita e i sogni infranti di Gigliola e la tragica fine della cameriera Nice e della ragazza francese. Tutte donne, tutte vittime dell’amore e di quel fardello che a volte è esser donne in una società fatta da e per gli uomini.
La moda / le mode
Gli anni precedenti alla guerra, la borghesia li trascorre al teatro San Carlo, ascoltando la musica dei compositori classici come Vivaldi ma senza disdegnare le canzoni popolari, mangiando in eleganti ristoranti sulla costa, passeggiando per le strade di Napoli con gli abiti alla moda e osservando le vetrine dei negozi. La moda fa da padrona. Sono gli anni in cui imperversa la moda parigina con le linie scivolate, la cravatta anche per le donne e il jabot (lo sparato).
“Vestirsi resta sempre una bella cosa, un fatto allegro, spensierato. I vestiti oltretutto rappresentano un fatto essenziale perché sono testimoni di ogni momento della vita, è come se fossero compagni, amici, complici.”
Alle frivolezze della moda parigina subentrerà nell’ultima parte del libro, l’austera arte dell’arrangiarsi, adattando vecchi vestiti alla meno peggio e i calzettoni di lana, durante la guerra, prenderanno il posto delle eleganti calze di nylon.
La cucina
Dove si dice Napoli si dice cucina. E cosi che tutto il romanzo è pervaso dai sapori dei piatti tipici, dalla genovese e la parmigiana allo spumone. La forza descrittiva di questi passaggi ha per effetto un tripudio di profumi, colori e sapori vivo nella nostra immaginazione. L’abbondanza dei piatti andrà diminuendo fino a ridursi ad un’alimentazione di guerra. In cui i prodotti di prima necessità vengono razionati e hanno costi astronomici al mercato nero. Al pane si sostituiscono le patate, il famoso caffè napoletano diventa un lusso cui possono accedere solo i gerarchi fascisti e tutti gli altri improvvisano un caffè di cicoria.
La narrazione e lo stile
Questo romanzo può essere considerato, infine, un atto di amore dell’autrice nei confronti di sua zia Rosella. La Mozzilo racconta, infatti, una storia della sua famiglia e lei stessa rimane ben presente nel romanzo. Una presenza certo non ingombrante, in quanto non interferisce direttamente con la narrazione principale. L’autrice si ritaglia degli spazi di poche pagine, delle annotazioni in corsivo tra i capitoli principali, delle testimonianze di prima mano se vogliamo. Lo stile di scrittura è di un italiano antico, elegante e evocativo, i dialoghi sono caratterizzati dall’uso frequente del dialetto napoletano borghese dell’epoca prebellico. Il gran numero di aggettivi, le ripetizioni incalzanti, l’uso di frasi brevi ad effetto conferiscono alla scrittura un ritmo veloce, come un fiume in piena. La narrazione risulta così intrisa di un senso di fatalità che si adatta a quel flusso inarrestabile della corrente chiamata Storia, che trascinerà i personaggi nel loro ineluttabile destino.