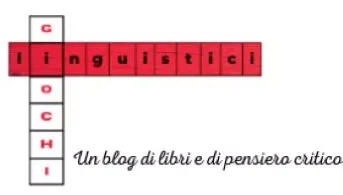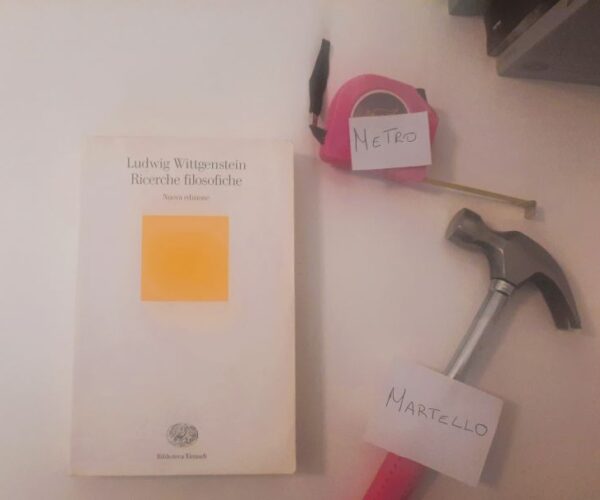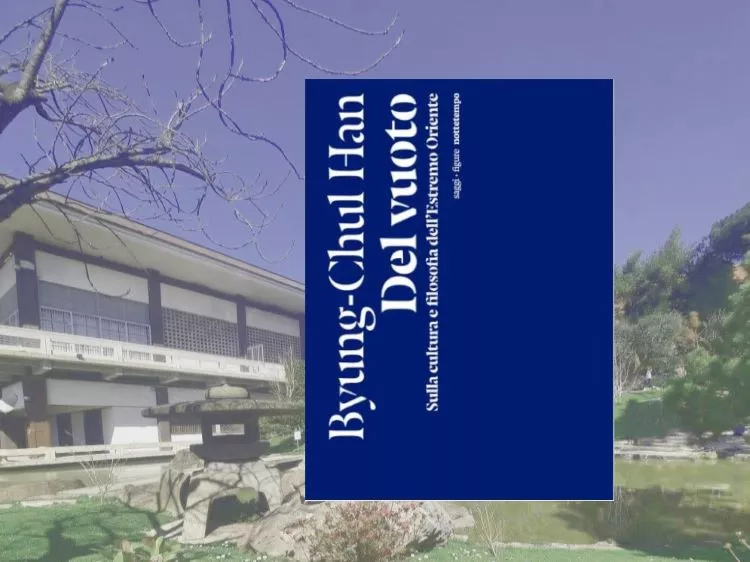
Del vuoto. Sulla cultura e filosofia dell’Estremo Oriente
Siamo un prodotto del Cristianesimo, la nostra filosofia greco-cristiana è permeata da categorie, pensiamo a blocchi contrapposti: Bene e Male, spirito e corpo. Figli di un dualismo cartesiano che nonostante i diversi tentativi della filosofia dialettica non siamo mai riusciti davvero a superare. Ci ha provato, tra gli altri, Giorgio Agamben soffermandosi, nelle sue riflessioni, sul tra, quell’elemento che si trova preso nelle eterne dicotomie che fanno l’Uomo: soggetto e oggetto, Io e l’Altro, Cultura e Natura. Se non altro dal punto di vista occidentale, ma se provassimo a pensare oltre questa nostra tradizione?
Forse ci voleva la prospettiva di un pensatore che quel tra lo incarna per cercare di dare spazio a un ripensamento delle nostre categorie oltre le categorie stesse. Byung-Chul Han è un conoscitore tanto della filosofia occidentale quanto di quella orientale. Nato in Corea del Sud nel 1959, dove ha trascorso la sua infanzia e prima giovinezza, si è trasferito negli anni Ottanta in Germania. È qui, tra Svizzera tedesca e Germania – immerso nella più pura tradizione filosofica occidentale da Kant, ad Hegel, fino ad Benjamin ed Heidegger – che Han ha conseguito i suoi studi filosofici. A questi è seguita una brillante carriera accademica, oggi portata avanti presso la Universität der Künste di Berlino.
Bisogna andare indietro, quasi all’inizio della sua carriera, per rintracciare la genesi delle sue speculazioni intorno al concetto di ab-essenza (Abwesen) o, secondo la traduzione italiana che dà il titolo al saggio, del vuoto. Risale, infatti, al 2007 la prima pubblicazione del saggio dal titolo Abwesen. Zur Kultur und Philosophie des Fernen Ostens, ma è solo di recente, con il notevole e lungimirante sforzo delle edizioni Nottetempo di tradurre i saggi del pensatore, che il pubblico italiano non germanofono può apprezzare questo tassello mancante nel pensiero di Byung-Chul Han.
Ed il lettore ne apprezzerà, ne sono sicura, anche la delicatezza della scrittura e la chiarezza espositiva, che lo ha reso – oltre al merito per i temi trattati – il filosofo pop del momento.
Sul termine Abwesen
In questo saggio Byung-Chul Han usa un modello di indagine archeologica della lingua che ricorda quello di Heidegger. Lo scavo che porta fin verso al senso originario di una parola lo accomuna ancora una volta ad Agamben, d’altronde entrambi i pensatori hanno gli stessi filosofi di riferimento. È nella creazione di neologismi che Han si avvicina ad Heidegger: cos’altro è ab-essenza (Abwesen) se non un neologismo sull’orma heideggeriana? Il tutto risulta più chiaro se si guarda alla lingua tedesca.
Han parte dalla parola tedesca wesen che, tra le altre cose, significa essenza e vi aggiunge il prefisso ab- indicante la negazione della parola che segue. La parola che ne risulta somiglia ad una esistente in tedesco Awesend, “colui che è assente”, ma non è questo significato a catalizzare l’attenzione del nostro filosofo. Il focus di Han è la sottrazione, il ritirarsi dell’essenza. Sorprendentemente per il nostro modo di vedere, quello che dovrebbe trovarsi in questa sottrazione non è però un’assenza da percepirsi come negativa e privativa, quanto piuttosto un nuovo modo di concepire la nostra natura. Il vuoto, per Han, è un luogo di silenzio e di pace.
La prospettiva presentata da Han in Del Vuoto. Sulla cultura e filosofia dell’Estremo Oriente vuole fare luce su un modello di vita alternativo a quello proposto dalla filosofia occidentale. Quest’alternativa sembra trovarsi nella filosofia orientale buddista e Zen: una cultura del vuoto, dell’ab-essenza per l’appunto.
La cultura occidentale fondata, invece, sull’essenza sarebbe, negli occhi di Han, una cultura di prevaricazione sull’altro a vantaggio del proprio Io. L’archeologia linguistica del termine wesen ce lo conferma. Essa ci porta al concetto dell’abitare, del dimorare. Il soggetto per poter sostare, stabilmente in questa dimora ha bisogno di imporsi. Così facendo si contrappone all’altro da sé. Han contrappone a questo concetto di dimorare, quello taoista di “vagabondare” un non-abitare.
Il buon viandante non lascia tracce dietro di sé (Laozi), poiché la traccia punta in una determinata direzione, ovvero indica un individuo attivo e le sue intenzioni. Il vagabondo di Laozi non persegue invece alcuna intenzione, non va da nessuna parte. Egli […] si fonde del tutto con la via.
Han procede nel saggio in questa direzione tracciando un confine netto tra cultura occidentale e cultura orientale ed estende questa contrapposizione anche ad altri ambiti generici della vita umana come quello della cucina, dell’architettura, dell’Illuminazione (ombre e luci) e, immancabilmente, della lingua.
Critiche e spunti di riflessione
Han, al tempo della pubblicazione di Del vuoto, ha ricevuto delle critiche da parte di alcuni intellettuali tedeschi che hanno definito le sue speculazioni utopistiche – volendo piuttosto connotarle come arbitrarie e parziali – ponendo l’accento su come la Cina Moderna offra un modello politico-sociale tutt’altro che perfetto. La pragmaticità tedesca odierna sembra dimenticare la tradizione metafisica, che eppure ha visto il suo sviluppo proprio in terra germanofona, presentando una critica che non sembra supportata dall’intento di Han: le speculazioni del filosofo sono espresse da un punto di vista prettamente metafisico-linguistico, l’aspetto socio-politico odierno, al di là della filosofia orientale, non rientra nelle sue riflessioni.
Han, d’altra parte, tocca un problema socio-culturale reale delle culture occidentali, pur restando il suo discorso metafisico. La grande aporia creata dal pensiero dualistico, e poi confermata dalla psicanalisi, è quella di un Io che si contrappone e impone su l’Altro. L’esclusione o l’assoggettamento dell’Altro, sembrano le sole dinamiche possibili. Dinamiche facilmente riconoscibili nelle nostre società contemporanee.
Lo conferma ancora una volta lo scavo archeologico linguistico. Han ricorda come lo stesso termine salutare grüßen, che ora noi intendiamo come una presa di contatto per avvicinarci all’altro è riconducibile al termine gruozen che vuol dire piuttosto sfidare, aggredire. E vorrei aggiungere, che lo stesso è rintracciabile nella lingua italiana, se ci pensiamo bene, quello che è riconosciuta come una comune forma di saluto ciao deriva dal dialetto veneziano e significa originariamente “vostro schiavo”. Entrambe le forme di saluto, seppur in maniera contrapposta, rimandano alla dialettica servo-padrone hegeliana.
Byung-Chul Han nel corso degli anni si è concentrato sull’approfondimento di tematiche che toccano il vivere, o meglio il mal di vivere, nelle società contemporanee: la stanchezza, il burn-out, la depressione. Le nostre società, impregnate di un malessere che non riescono più a gestire, urlano per un cambiamento. Han ci mostra la via, un’alternativa che non impone l’Io. “Un paese dove uno che dice io sprofonda subito sotto terra.” Una cultura per l’Altro e non contro l’Altro. Una cultura di cui, ora più che mai, abbiamo disperatamente bisogno.
Byung-Chul Han è il vincitore del Premio della Principessa delle Asturie 2025 per la comunicazione e le scienze umane.
Scheda del saggio Del vuoto. Sulla cultura e filosofia dell’Estremo Oriente di Byung-Chul Han

Titolo: Del vuoto. Sulla cultura e filosofia dell’Estremo Oriente
Autore: Byung-Chul Han
Casa editrice: Nottetempo edizioni
Anno di pubblicazione: 2024
Numero di pagine: 144
Traduzione di Simone Aglan-Buttazzi